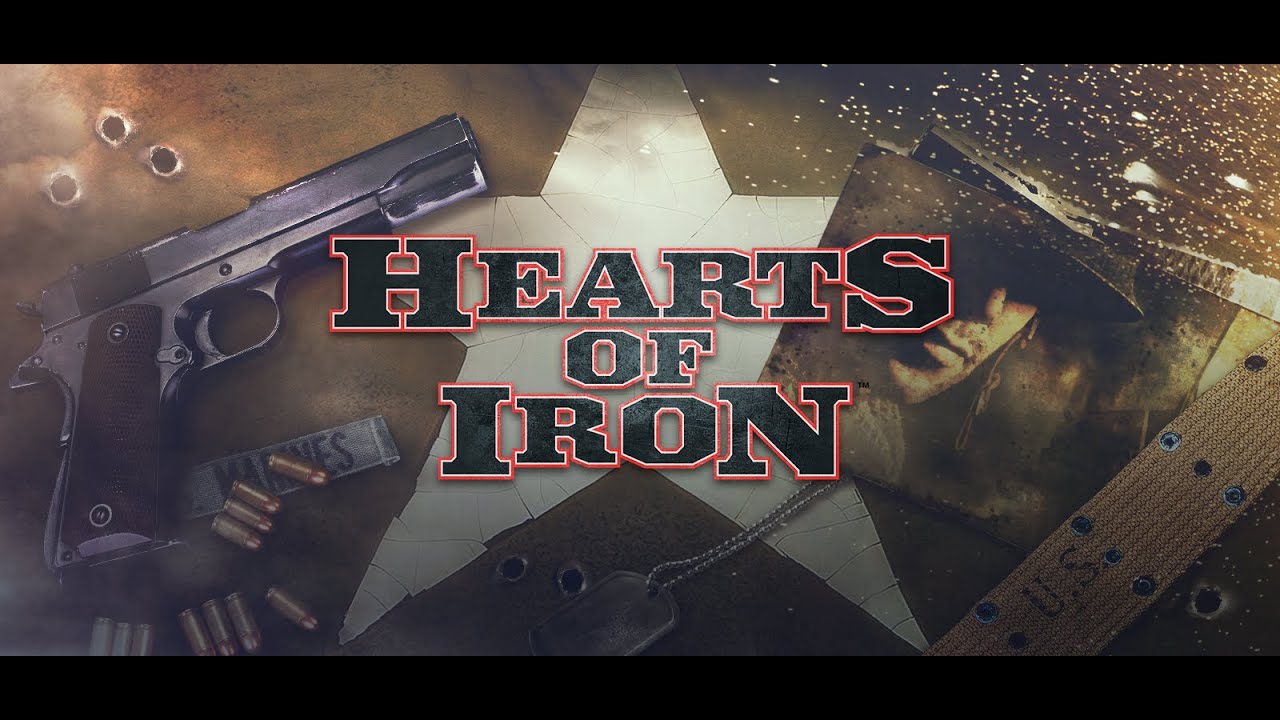Ci sono giochi che segnano un punto di svolta personale, ed è il caso di Strategic Command di Fury Software.
Devo ammetterlo: fu uno dei primi giochi che provai inizialmente in maniera “non legale”. Mi piacque così tanto che decisi di comprarlo online in edizione fisica, e da lì in poi ho scelto di acquistare sempre i miei giochi, proprio per gustarmeli fino in fondo senza il retrogusto amaro della copia pirata. Strategic Command è stato quindi non solo un titolo che mi ha appassionato, ma anche il punto di partenza di un nuovo modo di vivere il videogioco. L’ho finito in tutte le maniere possibili, esplorando ogni scenario, ogni campagna, eppure il suo seguito non mi ha mai dato le stesse emozioni.
Un wargame che mancava
All’epoca si sentiva davvero la mancanza di un wargame di questo tipo: semplice da apprendere ma incredibilmente coinvolgente. Lo sviluppatore era un singolo programmatore canadese, Hubert Cater, che con la sua Fury Software riuscì a realizzare un titolo capace di conquistare un pubblico di appassionati. Pubblicato dalla Battlefront, Strategic Command dimostrò che anche un gioco di “nicchia” poteva avere successo senza essere prodotto da grandi team.
Il gioco copre l’intera Seconda Guerra Mondiale su una mappa che va dalla costa orientale degli Stati Uniti fino agli Urali, dalla Scandinavia al Nord Africa. Ogni esagono rappresenta circa 80 chilometri, e le unità spaziano dai corpi d’armata alle flotte aeree, fino ai gruppi corazzati. Il tempo è scandito in turni che simulano settimane o mesi a seconda della stagione: un sistema pratico che evita di appesantire il gameplay con penalità legate al clima.
Le prime impressioni
Già dalla Beta Demo, Strategic Command colpì gli appassionati che lo paragonarono subito a vecchi classici come Clash of Steel. Io stesso, incuriosito, provai quel titolo storico per DOS, ma tornai rapidamente alla Beta di SC: più moderno, più accessibile, più immediato.
La grafica era semplice ma funzionale, con una risoluzione fissa a 1024×768. Non era certo paragonabile alle produzioni “tripla A”, ma bastava a restituire chiarezza e ordine sul campo di battaglia. Grazie anche alle mod grafiche create dai fan, era possibile personalizzare unità e interfaccia, persino sostituendo le icone con i simboli militari NATO.
Il sonoro era essenziale ma ben curato: effetti differenziati per le varie unità e una breve musica introduttiva. Mancava una colonna sonora di sottofondo, ma questo lasciava spazio al giocatore di scegliere la propria musica preferita.
Economia e politica
Il modello economico era semplice ma efficace. Ogni risorsa strategica – città, porti, miniere, pozzi petroliferi – contribuiva agli MPP, i “Military Production Points”. Con essi si poteva fare tutto: rinforzare unità, costruirne di nuove, o investire in ricerca.
La ricerca era divisa in undici settori: dalle armi anticarro ai carri pesanti, fino alla tecnologia missilistica o ai sistemi antiaerei. Ogni settore aveva cinque livelli di sviluppo, e più MPP si investivano, più aumentava la probabilità di progresso.
La politica seguiva lo stesso principio: poche opzioni ma incisive. Si poteva scegliere l’entrata in guerra delle grandi potenze in modalità storica, neutrale o casuale. Quest’ultima opzione, in particolare, rendeva il gameplay imprevedibile, perché le nostre mosse influenzavano direttamente le scelte delle nazioni neutrali.
Terra, cielo e mare
Il cuore del gioco erano, ovviamente, le unità militari. Dodici tipologie diverse, divise tra esercito, aviazione e marina. Ogni unità aveva parametri specifici: rifornimenti, esperienza, prontezza al combattimento, trinceramento, punti azione, valori di attacco e difesa.
Molto importante era la gestione delle unità HQ, i comandi di armata, che prendevano il nome da generali realmente esistiti. La loro vicinanza influenzava positivamente le truppe e, a loro volta, guadagnavano esperienza a seconda delle battaglie. Un rapporto reciproco che dava un tocco di realismo alla catena di comando.
Le manovre di accerchiamento erano spettacolari: usare i gruppi corazzati per tagliare fuori i rifornimenti nemici e ridurli all’impotenza era una delle soddisfazioni più grandi. La guerra navale aveva il suo peso, soprattutto con i sommergibili tedeschi che potevano colpire i convogli alleati, indebolendo la loro economia. Non mancavano neppure gli sbarchi anfibi e l’importanza dell’aviazione, decisiva per supportare le operazioni terrestri e navali, o per colpire con bombardamenti strategici.
Intelligenza artificiale e multiplayer
L’IA era sorprendente per un titolo sviluppato da una sola persona. Ricordo una mia partita in cui, mentre ero concentrato sul fronte russo, l’IA mi colpì con uno sbarco anticipato in Normandia: una mossa imprevista che mi mise seriamente in difficoltà.
Certo, un giocatore umano rimane sempre più creativo e imprevedibile, ed è per questo che molti si spostarono sulla modalità multiplayer. All’inizio erano disponibili solo le modalità Hotseat e PBEM (Play by Email), con tutti i limiti del caso, ma era chiaro che il futuro sarebbe stato il multiplayer online via TCP/IP.
Conclusioni personali
Strategic Command non era un titolo perfetto, ma aveva una qualità che oggi è rara: la capacità di tenerti incollato allo schermo per ore con un gameplay semplice e diretto, ma al tempo stesso ricco di possibilità.
È stato uno dei giochi che più ho amato e consumato, finito in tutte le maniere possibili. Ancora oggi lo ricordo con affetto, e nonostante i suoi seguiti abbiano provato ad ampliare e modernizzare la formula, nessuno di loro è riuscito a darmi le stesse emozioni.
Per me resterà sempre speciale, non solo come videogioco, ma anche come esperienza personale: il primo titolo che scelsi di acquistare legalmente online, con supporto fisico, e che segnò il momento in cui decisi di abbandonare definitivamente la pirateria. Da allora i giochi li ho sempre comprati, e credo che sia anche grazie a Strategic Command che ho imparato ad apprezzarli fino in fondo, rispettando il lavoro di chi li crea.